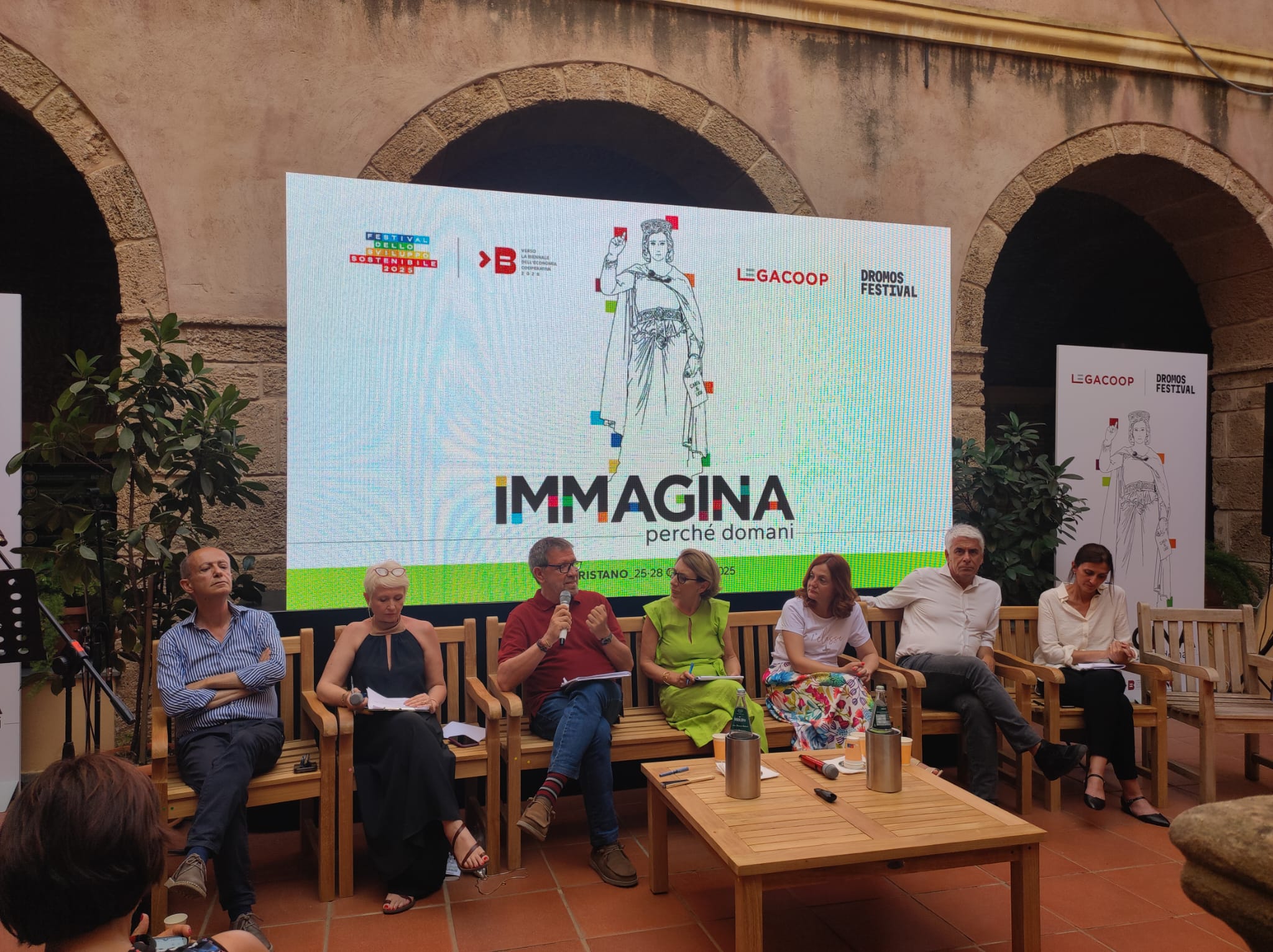La pastorizia è da sempre la spina dorsale delle aree interne e montane. Promotori di un cambiamento culturale, i pastori stanno avviando un percorso di lavoro comune per proporsi come soggetti attivi sui tavoli nazionali e regionali in cui si decidono le politiche territoriali.
Il 23/24 ottobre 2018 si è svolto a Cascia (Perugia) il Workshop con gli allevatori dell’Area Interna Valnerina. Presente all’iniziativa, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo Alessandra Pesce, Tra gli altri interventi istituzionali quelli del sindaco di Cascia Mario De Carolis, del Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche Giovanni Filippini e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria Fernanda Cecchini. Il workshop è un’attività del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) per la Rete Rurale Nazionale, svolta nell’ambito del Comitato Tecnico Aree interne (CTAI) a sostegno della definizione della strategia. L’evento è stato realizzato con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e dei centri Politiche e Bio-economia (PB) e Zootecnia e Acquacoltura (ZA) del CREA.
L’approccio seguito nella sua realizzazione si pone su una frontiera sia in termini di metodo di lavoro, basandosi sull’interazione tra operatori e ricercatori, che per le finalità perseguite essendo orientato a sostenere la co-progettazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati a partire dai fabbisogni degli operatori e dalla concreta valutazione delle azioni da mettere in campo per la zootecnia dell’area.
Nello specifico l’iniziativa si è posta l’obiettivo di approfondire le opzioni di valorizzazione disponibili per le filiere zootecniche e si è rivolta ai produttori locali e, in un’ottica interattiva, agli altri attori rilevanti per le filiere interessate (allevatori, veterinari, agronomi, istituzioni locali, associazioni di categoria). Lo scopo del workshop è stato fornire un supporto conoscitivo adeguato alle scelte della strategia e facilitare l’interazione tra operatori e ricercatori rispetto alle specificità della realtà tecnica e produttiva locale.
Sulla base degli esiti del workshop con gli allevatori è stato possibile mettere a fuoco i principali fabbisogni, anche in termini di conoscenza, e avviare inoltre un confronto sui temi trattati con le istituzioni locali e gli altri operatori rilevanti per i comparti di riferimento. Le due giornate hanno evidenziato l’esistenza di ostacoli la cui rimozione è funzionale all’innovazione del potenziale produttivo dell’area e alla sua valorizzazione. Per il comparto ovicaprino i nodi da sciogliere riguardano principalmente l’aggiornamento delle competenze tecniche e la gestione del rischio imprenditoriale da risolvere attraverso la messa in campo di un supporto mirato nell’ottica della consulenza e formazione necessarie ai produttori per intraprendere consapevolmente e sostenere processi di valorizzazione e diversificazione produttiva.
Tali esigenze sono avvertite negli altri comparti con sfumature differenti. Nel comparto dei suini ad esempio la presenza di produttori innovativi che hanno già intrapreso percorsi aziendali virtuosi suggerisce la messa in campo di azioni per la costruzione di comunità e lo scambio di esperienze, mirate al rafforzamento della cooperazione tra i produttori, utili anche per gli altri comparti ma da affiancare ad altri strumenti. Si tratta di esperienze locali interessanti che vanno però razionalizzate attraverso una attenta valutazione dei punti di forza da valorizzare e di debolezza da risolvere.
Ulteriori ostacoli riguardano l’assenza di servizi funzionali allo sviluppo delle filiere zootecniche locali. Nel comparto bovino dove i vitelli vengono venduti prima dell’ingrasso è emersa l’esigenza di definire strategie che consentano di mantenere nell’area una quota maggiore di valore aggiunto. Il vincolo maggiore a tale sviluppo è l’assenza di centri per l’ingrasso locali, che dovrebbero tuttavia assumere una forma consortile. Funzionale allo sviluppo di tutti i comparti potrebbe essere inoltre la disponibilità di un servizio per la macellazione e più in generale di strutture in grado di assolvere a funzioni ulteriori nell’ottica di accrescere la dotazione di servizi per i produttori (sezionamento, conservazione, etc). Le scelte tra le diverse opzioni disponibili a questo riguardo vanno effettuate attraverso una attenta valutazione tecnico-economica che consenta il corretto dimensionamento degli impianti rispetto alle produzioni attuali e future, considerando le nuove tecnologie e le competenze professionali necessarie.
Tra le opzioni di valorizzazione emerse c’è la possibilità di certificazione biologica per il comparto dei suini a pascolamento brado. Per il comparto ovicaprino occorre stabilizzare la qualità focalizzando sui passaggi del processo produttivo suscettibili di miglioramento e ampliare la gamma dei formaggi offerti con un’attenzione anche al fresco, considerando però gli ulteriori servizi connessi (es. catena del freddo) forse non sostenibili dai singoli produttori. Per quel che concerne il comparto bovino è emersa l’indicazione a diversificare i prodotti in funzione della stagionalità dei consumi e dell’alimentazione animale. In generale occorre puntare sulle qualità organolettiche e sulle caratteristiche salutistiche dei prodotti ottenuti da animali allevati a pascolamento brado, che rispondono ai criteri del benessere animale.
Tra le numerose indicazioni operative di cui si è discusso e utili per declinare le opzioni individuate va segnalata l’esigenza di mettere in campo in primis un supporto di tipo formativo e consulenziale ai produttori che includa sulla scorta della scuola per pastori dei Paesi Baschi i temi rilevanti per le filiere pastorali e le relative produzioni (quali gestione dei pascoli, pratiche di pascolamento, pratiche sostenibili, alimentazione degli animali, tecniche di caseificazione e qualità dei prodotti, filiere e mercati).
Di estrema rilevanza sarebbero anche la definizione di capitolati tra i comuni nell’area per l’utilizzo dei prodotti agricoli locali nella ristorazione collettiva (mense scolastiche e ospedaliere) e privata (es. agriturismi) e la definizione di accordi pubblici-privati per l’utilizzo di aree boschive e seminaturali per il pascolo selettivo ed a rotazione nell’area del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Essenziale anche l’avvio di attività di associazionismo tra i produttori ma solo partire da esigenze comuni, concrete e condivise (quali la raccolta e il riutilizzo della lana come sottoprodotto da smaltire).
Foto da qui.