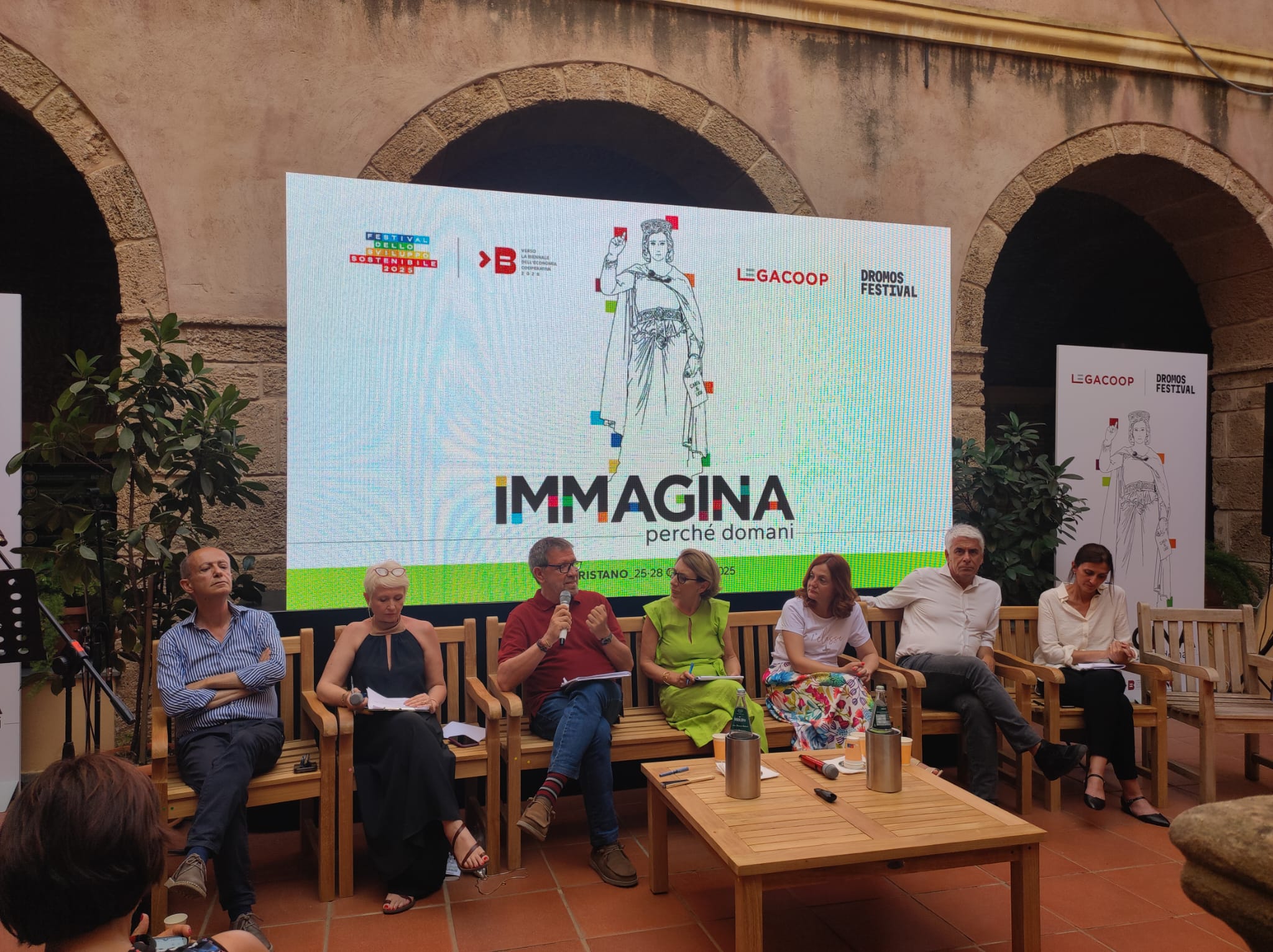Con la duplice sentenza sulla legge e sul referendum relativo all’”autonomia differenziata” la Corte Costituzionale si è assunta una grande responsabilità. Mentre ha ritenuto di non poter riconoscere al popolo il diritto di abrogare l’intera norma, ha individuato molteplici, gravi profili di incostituzionalità nella legge e ne ha fatto discendere alcuni requisiti indispensabili perché una nuova norma sia approvata. La rete di comitati territoriali che si è mobilitata contro l’autonomia differenziata può rilanciare il proprio impegno non solo spingendo perché quei requisiti siano soddisfatti davvero e non “per finta”, ma trasformandoli in obiettivi. La campagna da fare, in altri termini, non è più tanto quella di assicurare che non sia approvata una legge di attuazione del regionalismo che peggiora la condizione e le disuguaglianze degli italiani, ma di ottenere obiettivi che possono migliorare quelle condizioni e ridurre le disuguaglianze
Con la duplice sentenza sulla legge e sul referendum relativo all’”autonomia differenziata” la Corte Costituzionale si è assunta una grande responsabilità. Mentre ha ritenuto di non poter riconoscere al popolo il diritto di abrogare l’intera norma, ha individuato molteplici, gravi profili di incostituzionalità nella legge e ne ha fatto discendere alcuni requisiti indispensabili perché una nuova norma sia approvata.
Bene. La rete di comitati che in questi mesi ci ha consentito di parlare con le persone di sanità, scuola, disuguaglianze, partecipazione giustizia sociale e ambientale e di ritrovare il gusto del lavoro insieme e condiviso tra partiti, sindacati, intellettuali, civismo attivo, può rilanciare il proprio impegno per non lasciare la Corte sola nell’ottenere che quei requisiti siano soddisfatti davvero e non “per finta”, come già la Commissione Cassese sta facendo, ignorando le stesse considerazioni della Corte sull’ improprietà di affidare alla presunta tecnica ciò che della politica e del Parlamento.
Ma può fare di più. La rete di comitati può trasformare i principali requisiti fissati dalla Corte in obiettivi.
La campagna da fare, in altri termini, non è più tanto quella di assicurare che non sia approvata una legge di attuazione del regionalismo che peggiora la condizione e le disuguaglianze degli italiani, ma di ottenere obiettivi che possono migliorare quelle condizioni e ridurre le disuguaglianze.
Così formulati gli obiettivi della campagna assomigliano a quelli dei referendum approvati dalla Corte: migliorare la condizione e il benessere delle persone.
Ecco, con riferimento alla prima sentenza della Corte (n. 192/2024), i 3 principali obiettivi da perseguire e gli argomenti della Corte a cui fare riferimento.
- Creazione del Fondo perequazione nazionale previsto dall’articolo 119 della Costituzione
La Corte, si afferma nella sentenza, “non può esimersi dal rilevare che è improcrastinabile l’attuazione del fondo perequativo previsto dall’ art. 15 del d.lgs. 68/2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo cooperativo disegnato dalla L.42/2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente una equilibrata gestione”.
La Corte “evidenzia che le norme relative a tali processi sono state sistematicamente rinviate, di anno in anno, dal tempo della loro emanazione, con ciò impedendo il completamento del modello: la finanza regionale è rimasta … priva di meccanismi perequativi …. Questa Corte sottolinea dunque con forza la necessità di dare compiuta attuazione al descritto disegno … interrompendo una volta per tutte la pratica dei sistematici rinvii seguita fino ad oggi”.
- Fissazione da parte del Parlamento delle funzioni (non materie) per le quali fissare il LEP e relazione con in non-LEP
La determinazione dei LEP non può essere rimessa al solo Governo, che li stabilisce con decreti legislativi sulla base di una delega priva di principi e “idonei criteri direttivi”, estromettendo il Parlamento dal ruolo costituzionale attribuitogli in merito alla garanzia dei diritti fondamentali e alla definizione, con legge, dei principi con cui devono essere assicurati
In particolare, la Corte sottolinea “che il LEP implicano una delicata scelta politica perché si tratta di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti ed esigenze finanziarie e anche i diversi diritti tra loro”
La Corte ha “ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge:
- il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
- la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l’aggiornamento dei LEP;
- il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP”.
Si afferma, inoltre, che “La limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se invece lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia non-LEP e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP”.
- Determinazione dei fabbisogni finanziari necessari per raggiungere tali livelli.
Si tratta, evidentemente, dell’obiettivo che dà senso ai primi due. Un passaggio che nessun governo e tanto meno questo vuole compiere, perché renderebbe evidente – si pensi ai LEA già esistenti – che il conseguimento dei livelli essenziali di prestazione non è possibile con le attuali risorse assegnate. Viceversa, compiere questo passo indurrebbe a una rigorosa ri-pianificazione dei sistemi di servizio esistenti che parta dai livelli da garantire, ad una valutazione delle opportunità tecnologiche esistenti e prospettiche e quindi alla ricerca delle modalità di copertura finanziaria, ovviamente nella direzione di un ripristino della progressività fiscale persa. Si potrebbero anche determinare le risorse da mettere a disposizione del Fondo perequativo.
Tutto questo non è scritto in modo dettagliato nella sentenza della Corte, ma l’obiettivo è espresso in modo chiaro. Si legge: “La determinazione dei LEP origina il dovere dello stato di garantirne il finanziamento: è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”
La scelta dei LEP è una scelta precisa della Costituzione che, nei lavori preparatori sostituisce la dizione “livelli minimi di garanzia” allo scopo di assicurare uno standard superiore a quello minimo per attuare pienamente l’art. 3 (rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana). Una volta definiti, i LEP sono “una soglia vincolante per le autonomie locali. Coerentemente la determinazione dei LEP implica che gli enti territoriali dispongano delle necessarie risorse, attraverso i canali previsti dall’art. 119, quindi anche attraverso il Fondo perequativo”.
La Corte ribadisce che “se l’individuazione dei LEP fa sorgere maggiori oneri, si possono trasferire le funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i LEP sull’intero territorio nazionale”.