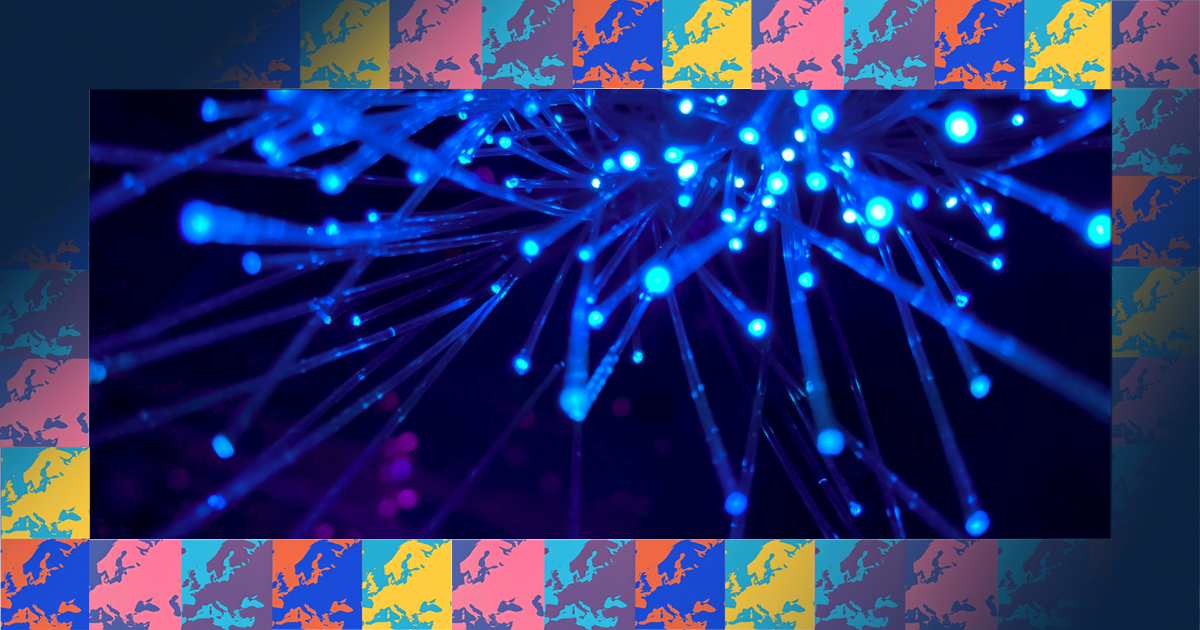Un commento sul diverso approccio tenuto da Europa e Stati Uniti sulle valute digitali (approfondimento al secondo numero della newsletter “Quale Europa. Cronache per capire, discutere, scegliere”)
Il 17 giugno 2025 il Senato americano ha compiuto un passo decisivo approvando il GENIUS Act. Questa legislazione rappresenta la prima cornice normativa federale per le stablecoin (un tipo di criptovaluta in cui il valore dell’asset digitale è ancorato a un asset di riferimento) ad essere approvata da una delle due camere del Congresso dopo anni di dibattito, e ora si dirige verso la Camera dei Rappresentanti.
Questo sviluppo segna un momento cruciale nel panorama globale delle valute digitali, dove Europa e Stati Uniti stanno giocando due partite molto diverse. L’UE sta sviluppando l’Euro Digitale, una valuta pubblica sotto il controllo della Banca Centrale. Gli Stati Uniti, invece, con l’approvazione del GENIUS Act, sembrano aver rafforzato la loro visione di delegare la moneta digitale a stablecoin private denominate in dollari, lasciando che siano queste a portare la bandiera del dollaro nell’era digitale.
Questa non è solo una differenza tecnica: è uno scontro di visioni sul ruolo dello Stato, del mercato e della tecnologia nella finanza globale. L’Europa, con tutti i suoi limiti, sta cercando di difendere l’idea che il denaro, anche nella sua forma digitale, debba restare un’infrastruttura pubblica, accessibile e governata democraticamente. Gli USA, al contrario, sembrano voler esternalizzare questa funzione a soggetti privati, spesso opachi e con incentivi distorti, nella speranza che il “primato dell’innovazione” garantisca il predominio del dollaro.
In pratica: si normalizza il fatto che aziende private, molte delle quali con base offshore e controllate da investitori speculativi, possano emettere strumenti quasi-monetari con impatti sistemici. Il fatto che queste siano ancorate al dollaro non rende la cosa meno rischiosa, anzi: consolida una forma di dominio monetario digitale senza responsabilità pubblica né controllo democratico.
Ma quali sono i rischi concreti di questa “abdicazione” dello Stato? Le stablecoin, per loro natura, non sono immuni da problemi. Uno studio del 2023 della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements) ha rivelato che tutte le 60 stablecoin esaminate avevano perso il loro ancoraggio almeno una volta.
Esiste poi il rischio di controparte, che include frodi, hacking o fallimenti dell’emittente, lasciando i detentori senza una rete di sicurezza oltre al capitale proprio dell’azienda. A differenza della moneta Fiat (valuta nazionale non ancorata al prezzo di una materia prima come oro o argento), le stablecoin non sono universalmente intercambiabili, il che aggiunge costi e complessità. E se queste valute private dovessero essere adottate su larga scala, potrebbero esercitare una pressione significativa sulla politica monetaria e sulla stabilità finanziaria, specialmente in Europa, con il rischio di deflussi di depositi in euro verso le stablecoin denominate in dollari.
L’illusione americana è che più mercato equivalga a più innovazione. Nel campo del denaro, tuttavia, più mercato può anche voler dire più instabilità, meno trasparenza e maggiore concentrazione di potere. Il rischio per l’Europa è concreto: se le stablecoin in dollari diventano lo standard de facto nei pagamenti digitali globali, l’euro rischia di perdere rilevanza anche in casa propria. In un contesto dove il contante sparisce e i grandi player tech (quasi tutti statunitensi) intermediano i pagamenti, la sovranità monetaria europea ne risulterebbe erosa.
È qui che l’Euro Digitale può giocare un ruolo chiave, se sarà progettato in modo ambizioso. Non basta creare un’alternativa pubblica: serve una vera infrastruttura europea per i pagamenti, interoperabile, sicura e accessibile. E serve la volontà politica di resistere alla finanziarizzazione estrema del digitale che sta facendo scuola oltreoceano. Come si sta già provando a fare in Cina, in India e in Brasile.