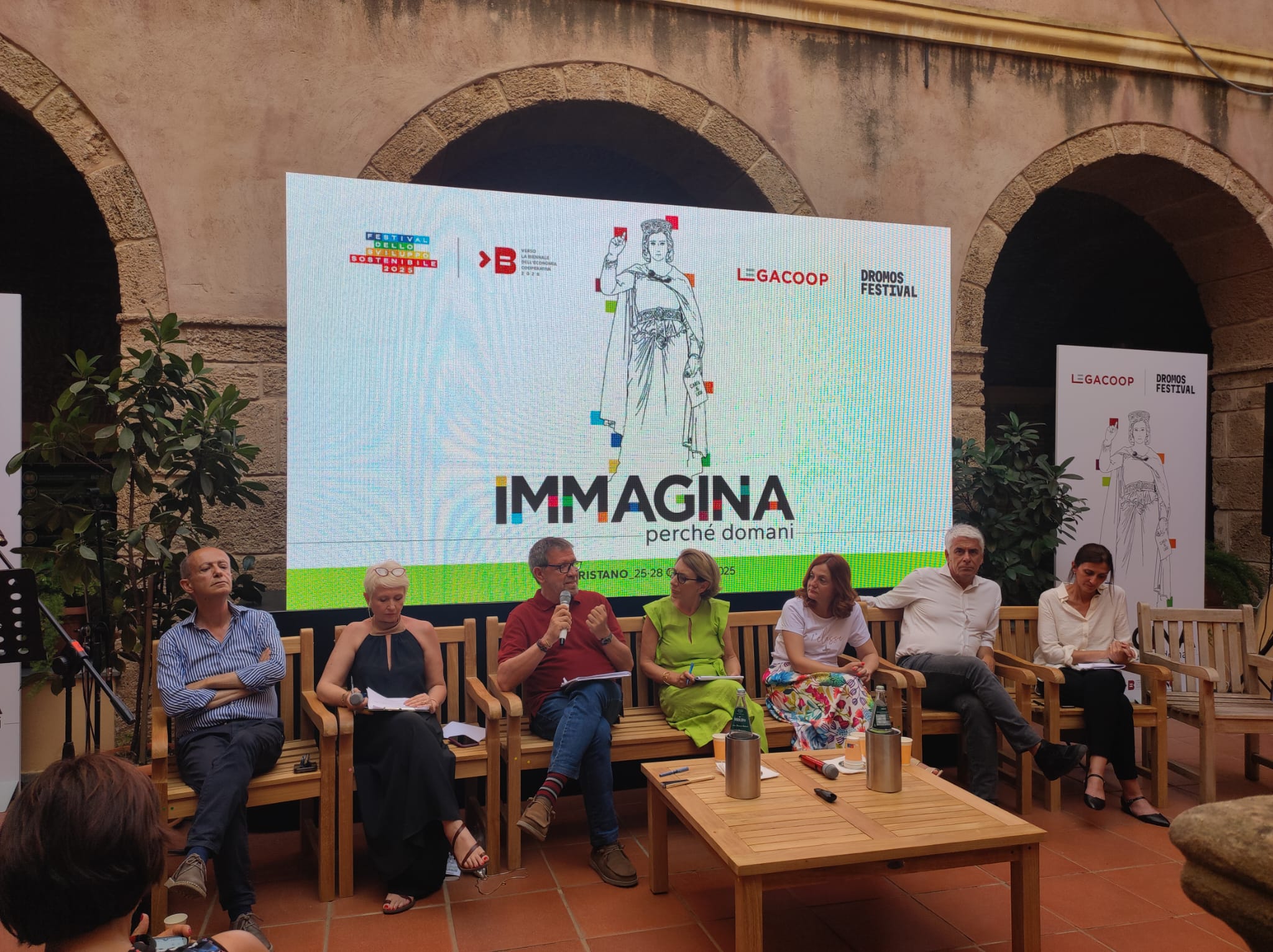Il Rapporto “Le Equilibriste” di Save the Children Italia analizza la maternità in Italia evidenziando le carenze di un welfare incapace di dare risposte a donne e famiglie in termini di sostegno alla cura di bambine e bambini
Per il decimo anno di seguito, Save The Children Italia ha pubblicato un rapporto sulla maternità in Italia analizzando dati di varia natura[1] relativi alle condizioni di vita, agli squilibri fra diritti, al rapporto fra vita e lavoro, alla gestione dei figli, della casa, degli impegni legati alla cura. Il titolo del rapporto, Le Equilibriste, è di per sé una tesi: le madri italiane di nuova generazione sono – o dovrebbero essere – come degli acrobati: capaci cioè di non cadere (e non far cadere gli accuditi) in situazioni di squilibrio, sempre più o meno rischiando di farsi molto male (o di farne a chi si ha in carico). Perennemente in una condizione di tensione, da fiato sospeso.
Si potrebbe pensare che la madre-acrobata sia tutto il contrario della madre-accudente che domina l’immaginario post-bellico occidentale; la madre, cioè, angelo del focolare e intenta a rassettare la casa, cucinare prelibatezze e occuparsi dei bambini mentre il marito breadwinner è al lavoro. L’acrobata è sempre a rischio (un rischio che si è cercata o che fa comodo ad altri?), la madre-casalinga invece ha tutta la giornata per pensare a come organizzarsi. Tuttavia, anche quella madre, come rivelato dal celebre testo di Betty Friedan (The Feminine Mystique, 1963), era depressa, ansiosa, dipendente (spesso dall’alcool), assente a sé stessa e nevrotica; anche quella donna, infatti, era oppressa da un ordine simbolico che la voleva in un certo modo.
Tra l’equilibrista e la casalinga disperata c’è una doppia continuità.
In primo luogo, tanto queste madri di oggi quanto quelle madri di ieri, che chiacchierano rassettando i fiori e si interessano delle vite degli altri, come nelle serie tv o in Revolutionary Road, non sono pienamente libere né autonome. Le prime faticano a cercare lavoro, a mantenerlo dopo la nascita del primo figlio e in generala soffrono la “child penalty”: 1 su 5 si dimette volontariamente, mentre gli uomini con almeno due figli sono addirittura più occupati di quelli senza o con un figlio. Tanto ieri come oggi le donne vivono dentro un modello che serve perfettamente un certo equilibrio economico ma non si cura dei loro desideri o del loro benessere mentre loro offrono lavoro riproduttivo gratuito (partoriscono, crescono e gestiscono i figli) e permettono al sistema produttivo di rigenerarsi e persino di crescere.
La differenza fra questi due modelli è che le equilibriste odierne sono anche, spesso, dei breadwinner: mantengono cioè anche economicamente la famiglia, a volte con il marito e a volte da sole. Alle madri single, “le equilibriste fra le equilibriste”, è dedicato un focus nel rapporto perché si tratta di un tema cruciale: fra il 1983 e il 2023 i nuclei monoparentali sono raddoppiati.
In secondo luogo, tanto le une quanto le altre sono soggetti che rischiano di scoppiare: le equilibriste perché non riescono a tenere tutti i pezzi della loro vita insieme armoniosamente, le casalinghe perché vivono un conflitto fra quello che la società vuole da loro (la cura) e quello che talora si accorgono di desiderare (una formazione, un lavoro, un’esperienza nuova come un viaggio). Questa tensione che interessa il soggetto femminile in genere e il soggetto materno in particolare è ben riassunta da una domanda che compare, non a caso, nel trailer di Revolutionary Road: “how can you break free without breaking apart?” (ossia: come puoi liberarti senza finire in mille pezzi?).
Ancora oggi, come testimoniato dai dati commentati nel rapporto, gli svantaggi che pesano sulle madri lavoratrici sono amplificati anzitutto dal sistema di welfare “familistico” tipicamente italiano, ovvero quel modello che scarica sulle famiglie quote troppo consistenti di servizio pubblico. Qualche esempio: i lunghi mesi di pausa estiva delle scuole, i lunghi ponti, la privatizzazione dei sistemi di sostegno, che costando molto pongono le famiglie (e soprattutto le madri lavoratrici) di fronte a scelte tragiche: mi lancio in quel progetto o evito di creare confusione a casa? Per non parlare delle donne disoccupate (più degli uomini) e delle inattive (anche in questo caso superiori agli uomini) e delle consuete differenze territoriali: il rapporto mostra un’Italia essenzialmente a tre velocità – con il Nord che arranca ma avanza rispetto al passato, il centro che ha valutazioni intermedie e il Sud con le isole che continua ad andare fortemente a rilento.
La rete che dovrebbe proteggere le equilibriste dal rischio di cadere è inoltre assente o bucata: è fatta di misure come l’alleggerimento fiscale o il trasferimento monetario. Ma per quale ragione un bonus darebbe maggior sollievo alle famiglie di strutture aperte, pubbliche, che tengano conto della frammentazione del lavoro e della sua multiformità? È chiaro, e lo sottolinea bene il report, che il welfare all’italiana è costruito intorno a lavoratori e lavoratrici che non esistono quasi più e si basa sul principio secondo cui i figli sono anzitutto delle famiglie.
Non a caso le raccomandazioni per il futuro vanno nel senso di affiancare ai vari bonus e ai programmi de-contributivi anche servizi più capienti e permanenti, gratuiti o comunque meno onerosi: vanno insomma nel senso di un sostegno circostante, permanente e diffuso per le famiglie (con bimbi fra 0-3 anni, ma non solo: anche per quelli in età scolare e per gli adolescenti). Soprattutto, di un sistema pubblico, progettato e costruito politicamente: non solidale o occasionale.
L’EIGE (l’istituto europeo sull’uguaglianza di genere) raccomanda inoltre di suddividere meglio il lavoro dentro la famiglia, fra uomini e donne. Certamente un consiglio sensato. Tuttavia, nelle famiglie con due genitori che lavorano (la stragrande maggioranza di quelle in cui vivono le equilibriste) il lavoro di cura è già piuttosto condiviso ma si fatica comunque. Oltre alle azioni utili per conciliare vita e lavoro (come il lavoro flessibile), i congedi ampliati e ben retribuiti, servono insomma, per concludere, degli investimenti ampi e duraturi sulla struttura e serve un ripensamento del modello di welfare, in modo che ciascun soggetto possa scegliere quale equilibrio dare alla propria esistenza. Equilibrio, sì: la radice è la stessa dell’equilibrismo, ma c’è un intero mondo ingiustizie in mezzo da smantellare.
[1] Prevalentemente elaborati da Istat, INPS, EIGE – European Institute for Gender Equality, e da uffici parlamentari e governativi responsabili di implementare il PNRR.